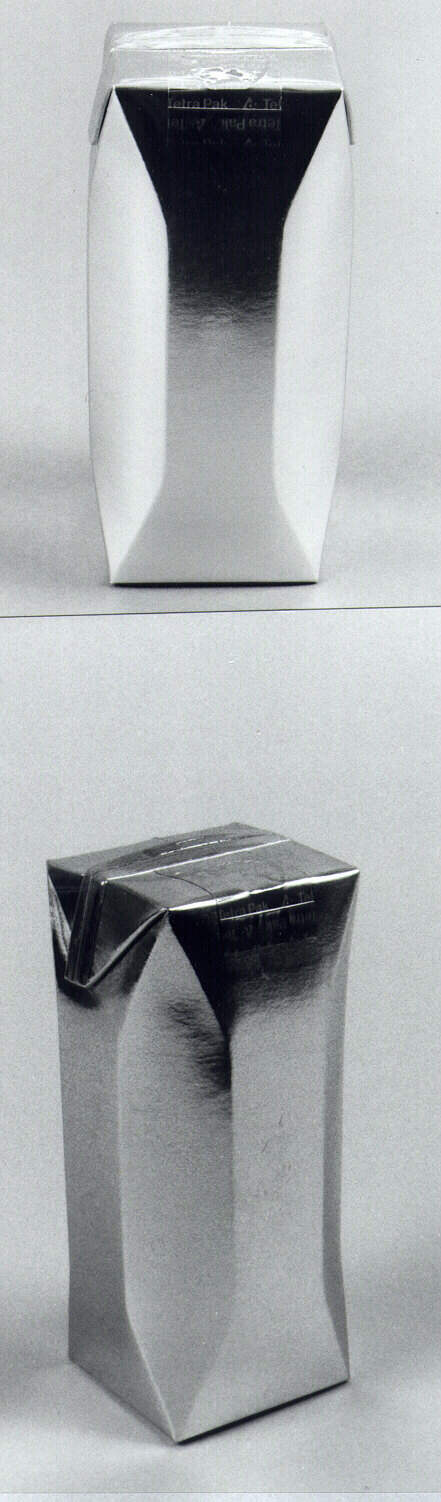Cass. sez. III, ord. 23/12/2024 n. 33.984., rel. Gorgoni, circa la pasta pasta dentaria Polident Imbattibile di Glaxo:
<<Un tanto pur dovendosi ribadire che:
i) il prodotto non è difettoso solo perché pericoloso; nel senso che il verificarsi del danno non prova indirettamente, di per sé, la pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego, ma solo una sua più indefinita pericolosità di per sé insufficiente per evocare la responsabilità del produttore, se non sia anche in concreto accertato che quella specifica condizione di insicurezza del prodotto si pone al di sotto del livello di garanzia di affidabilità richiesto dalla utenza o dalle leggi in materia (Cass. 29/5/2013, n. 13458; Cass. 29/5/2013, n. 13458; Cass. 13/12/2010, n. 25116; Cass. 23/10/2023, n. 29837);
ii) non esiste un prodotto del tutto innocuo (Cass. 10/05/2021, n. 12225, cit., osserva che “anche assumendo come parametro integrativo di riferimento la nozione di prodotto “sicuro” contenuta nella disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti di cui all’art. 103 Codice del consumo (e già al D.Lgs. n. 172 del 2004)(…) di sicurezza prescritto, al di sotto del quale il prodotto deve considerarsi difettoso, non corrisponde a quello della sua più rigorosa innocuità, dovendo farsi riferimento ai requisiti di sicurezza dall’utenza generalmente richiesti in relazione alle circostanze specificamente indicate all’art. 117 Codice del consumo (e già al D.P.R. n. 224 del 1988, art. 5), o ad altri elementi in concreto valutabili e concretamente valutati dal giudice di merito, nell’ambito dei quali debbono farsi rientrare gli standards di sicurezza eventualmente imposti dalle norme in materia (v. Cass. 20/11/2018, n. 29828; Cass. 29/5/2013, n. 13458)”) e che una certa dose di rischio può accettarsi purché sia ragionevole in relazione ad alcuni indici di valutazione proposti dal legislatore, i quali mediano tra i comportamenti esigibili dal produttore e le realistiche attese di sicurezza dell’utilizzatore, anche allo scopo di non imporre al produttore un costo elevato e inefficiente.
Un primo dato certo è allora che, come osservato dall’odierna ricorrente, la pasta adesiva solo perché conforme agli standard tecnici non è per ciò solo inidonea a provocare danni.
Nonostante il rilievo crescente attribuito alle norme tecniche emanate da organismi di normalizzazione (norme UNI e CEI in Italia), recepite o richiamate da provvedimenti legislativi, che il prodotto sia pienamente conforme agli standard tecnici – che siano espressamente prescritti dalle cosiddette normative verticali o che siano altrimenti desumibili dallo stato dell’arte – non implica che esso non sia potenzialmente dannoso (Cass. n. 12225/2021, cit.), quand’anche se ne possa presumere la sicurezza e, per converso, un prodotto difforme può risultare solo occasionalmente (ma non necessariamente) dannoso. Il prodotto conforme agli standard tecnici può risultare difettoso, perché dannoso, in considerazione del fatto che gli standard tecnici individuano una soglia minima di sicurezza il cui rispetto è indispensabile per ottenere la certificazione senza la quale non è possibile immettere in circolazione il prodotto, ma non esonera da responsabilità il produttore che non abbia fatto ricorso a misure precauzionali additive, purché fossero nella sua disponibilità (Corte di Giustizia CE, 29/05/1997, C-26/96, secondo cui le conoscenze scientifiche e tecniche di cui all’art. 7 lett. e) della Direttiva n. 85/374 non riguardano soltanto la prassi e gli standard di sicurezza in uso nel settore industriale nel quale opera il produttore, ma comprendono, senza alcuna restrizione, lo stato dell’arte inteso nel suo livello più avanzato, purché concretamente accessibile al momento della messa in circolazione del prodotto considerato).
Il ragionamento, in verità, non è dissimile da quello che si segue da parte di questa Corte quando si deve accertare la sussistenza di un comportamento colposo; il fatto che l’agente abbia osservato una norma cautelare esclude, di norma, la sua colpa specifica, ma tanto non esime dal verificare la sussistenza di una sua colpa generica [ottima precisazione].
Erra dunque il giudice a quo quando conferma la pronuncia del Tribunale che aveva “precisato come, in dipendenza della qualifica di presidio marcato CE, la parte adesiva era stata sottoposta ai controlli previsti dalla disciplina in materia” (p. 6 della sentenza), dopo avere osservato, atteggiandosi a giudice di legittimità, che l’appellante aveva riproposto la propria tesi difensiva, già disattesa dal giudice di primo grado, senza un effettivo confronto con la più ampia argomentazione presente nella sentenza impugnata (p. 6).
Ora, nel caso di specie la ricorrente per invocare la responsabilità del produttore ha fatto leva su uno dei tre difetti su cui è incentrata la definizione normativa di prodotto difettoso, vale a dire il difetto di informazione (gli altri sono i difetti di fabbricazione – uno o pochi esemplari della serie sono difettosi, per cattivo funzionamento dell’impianto di prodizione o per una svista di qualche operatore i difetti di costruzione – l’intera serie è difettosa a causa di inadeguata progettazione, mancanza di congegni di sicurezza, uso di componenti o materie prime inadatte, insufficiente sperimentazione ecc.) cioè la mancanza o l’insufficienza di informazioni date dal produttore per un uso corretto del prodotto e per evitare i rischi connessi al suo uso.
Detta informazione, sia quella tratta dalla presentazione del prodotto e dalle sue caratteristiche palesi, sia quella fornita dal produttore con istruzioni e avvertenze aggiuntive, ha un contenuto inversamente proporzionale alle ragionevoli attese di sicurezza del bene e deve essere contemperata con l’uso ragionevole del prodotto (secondo Cass. 15/03/2007, n. 6007, il riferimento normativo all’uso ragionevole del prodotto “delimita l’ambito del dovere di cautela del produttore, escludendo la garanzia di sicurezza in presenza di anormali condizioni di impiego le quali possono logicamente dipendere non solo dall’abuso e dall’uso non consentito, come potrebbe ritenersi ad una più sommaria lettura, ma anche da circostanze anomale che, ancorché non imputabili al consumatore, rendano il prodotto, altrimenti innocuo, veicolo di danno (alla salute)”)., nel senso che l’uso del bene per una finalità irragionevole esclude la difettosità del prodotto, mentre un uso non accorto potrà essere causa di riduzione del risarcimento dei danni (Cass. 14/06/2005, n. 12750), oltre che con il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
Il principio è chiaramente desumibile dall’art. 104,2 comma, cod. cons., ai sensi del quale il produttore deve fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto e alla prevenzione contro detti rischi, ma “la presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo”, cioè in sostanza non esenta dall’obbligo di “immettere sul mercato solo prodotti sicuri”(art. 104,1 comma, cod. cons.).
Nell’applicazione di detti principi, il giudice è tenuto a mettere a confronto le condotte delle parti in causa per valutare se il danno poteva essere più facilmente (cioè con minor sacrificio) evitato dalla vittima o dal produttore, alla luce delle informazioni di cui ciascuno dei due poteva disporre nel momento in cui ha agito, in uno con il rilievo attribuito ad una distinzione inespressa tra: i) danni prevedibili ed evitabili; ii) danni astrattamente prevedibili, ma inevitabili; iii) danni imprevedibili ed inevitabili. Il tutto sotto l’egida del parametro della ragionevolezza, quale strumento di concretizzazione e di bilanciamento di una pluralità di valori.
Esaminando specificamente il profilo del difetto di informazione, ha ragione la ricorrente quando osserva che l’informazione che si traduca in una mera avvertenza circa il fatto che un determinato evento possa verificarsi non vale ad esonerare il produttore da responsabilità; conducente è solo la veicolazione di informazioni che, come osservato da attenta dottrina, contribuisca “a prevenire un rischio evitabile o a soppesare adeguatamente quello che… non lascia altra scelta che accettarlo o rinunziare alle utilità del prodotto pericoloso. Un’avvertenza che non operi in un senso o nell’altro, ma si limiti a ricordare che le cose possono andare male e, su questa base, intenda isolare il produttore da responsabilità, val quanto una clausola di esclusione da responsabilità; e ne condivide le sorti”.
Non bisogna, nondimeno, trascurare il fatto che la responsabilità del produttore non è regolata alla stregua di una responsabilità oggettiva pura (o assoluta) e che perciò il comportamento dell’utente non è affatto irrilevante: esso deve essere improntato al principio di autoresponsabilità (codificato dall’art. 122 cod. cons., ai sensi del quale “Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto”) e deve essere valutato dal giudice, il quale dovrà accertare se vi sono i presupposti per ritenere che proprio l’utilizzatore si sia trovato nella condizione migliore per evitare o contenere il danno>>.