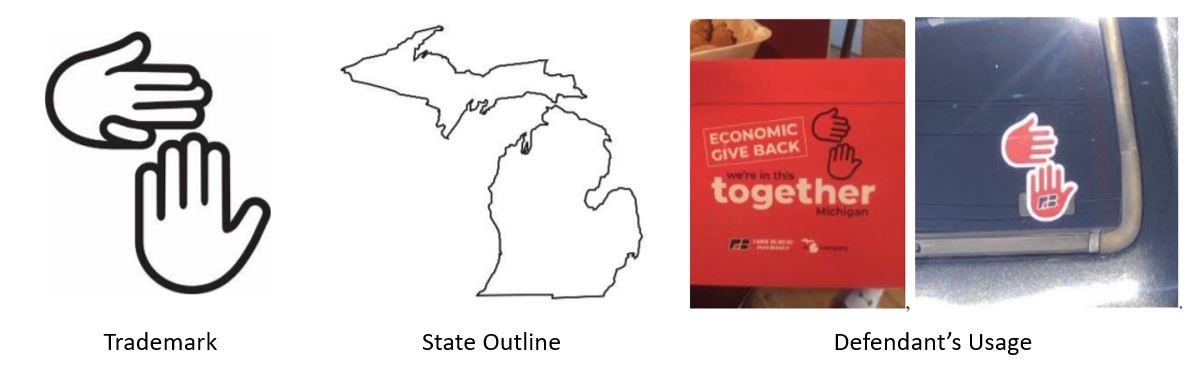La CG si pronuncia sulla legittimità ai sensi dei diritto sui generis sulle banche dati (art. 7 dir. 96/9) dell’attività di ricerca dati (offerte di lavoro) da parte di un motore di ricerca specializzato, effettuata su banca dati presente in internet e liberamente accessibile.
Si tratta di CG 03.06.2021, C-762/19, «CV-Online Latvia» SIA c. «Melons» SIA .
Precisamente: <<il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/9 debba essere interpretato nel senso che un motore di ricerca in Internet specializzato nella ricerca dei contenuti delle banche di dati, che copia e indicizza la totalità o una parte sostanziale di una banca di dati liberamente accessibile in Internet, e successivamente consente ai suoi utenti di effettuare ricerche in tale banca di dati sul suo sito Internet secondo criteri pertinenti dal punto di vista del suo contenuto, procede a un’«estrazione» e a un «reimpiego» del contenuto di tale banca di dati, ai sensi di detta disposizione, e che il costitutore di una siffatta banca di dati ha il diritto di vietare tale estrazione o reimpiego di questa stessa banca di dati.>, § 20.
Le nozioni di «estrazione» e di «reimpiego» devono essere interpretate <<nel senso che si riferiscono a qualsiasi atto consistente, rispettivamente, nell’appropriazione e nella messa a disposizione del pubblico, senza il consenso del costitutore della banca di dati, dei risultati del suo investimento, privando così quest’ultimo di redditi che dovrebbero consentirgli di ammortizzare il costo di tale investimento (sentenza del 9 novembre 2004, The British Horseracing Board e a., C‑203/02, EU:C:2004:695, punto 51)>>, § 31.
nel caso di specie il motore di ricerca specializzato sub iudice <<non utilizza i moduli di ricerca dei siti Internet nei quali consente di effettuare una ricerca e non traduce in tempo reale le richieste dei propri utenti in criteri utilizzati da tali moduli. Tuttavia, esso indicizza regolarmente tali siti e ne conserva una copia sui propri server. Inoltre, grazie al proprio modulo di ricerca, esso consente ai suoi utenti di effettuare ricerche in base ai criteri da esso proposti, ricerche che si effettuano tra i dati che sono stati indicizzati. Se è pur vero che il funzionamento del motore di ricerca come quello di cui trattasi nel procedimento principale è diverso da quello di cui trattavasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 19 dicembre 2013, Innoweb (C‑202/12, EU:C:2013:850), ciò non toglie che tale motore di ricerca consente di esplorare, seguendo un percorso diverso da quello previsto dal costitutore della banca di dati interessata, l’intero contenuto di più banche di dati simultaneamente, tra cui quella della CV-Online, mettendo tale contenuto a disposizione dei propri utenti. Tale motore di ricerca specializzato, fornendo la possibilità di effettuare ricerche simultaneamente in più banche di dati, secondo i criteri pertinenti dal punto di vista delle persone alla ricerca di lavoro, consente agli utenti l’accesso, nel proprio sito Internet, ad offerte di lavoro contenute in tali banche di dati.>>, §§ 33-34.
Pertanto, un motore di ricerca come quello di cui trattasi nel procedimento principale <<consente di esplorare tutti i dati contenuti nelle banche di dati liberamente accessibili in Internet, ivi compreso il sito Internet della CV-Online, e fornisce ai suoi utenti un accesso all’intero contenuto di tali banche di dati seguendo un percorso diverso da quello previsto dal loro costitutore. Inoltre, la messa a disposizione di tali dati si rivolge al pubblico, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/9, dal momento che un simile motore di ricerca può essere utilizzato da chiunque (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Innoweb, C‑202/12, EU:C:2013:850, punto 51) . 36 Inoltre, tale motore di ricerca, indicizzando e copiando sul proprio server il contenuto dei siti Internet, trasferisce il contenuto delle banche di dati costituite da tali siti verso un altro supporto. 37 Ne consegue che un simile trasferimento del contenuto sostanziale delle banche di dati interessate e che una simile messa a disposizione di tali dati al pubblico, senza il consenso della persona che le ha costituite, sono, rispettivamente, misure di estrazione e di reimpiego di tali banche di dati, vietate dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9, a condizione che esse abbiano l’effetto di privare tale persona di redditi che dovrebbero consentirle di ammortizzare il costo di detto investimento. Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, la fornitura dei collegamenti ipertestuali verso gli annunci che compaiono nel sito Internet della CV-Online e la riproduzione delle informazioni contenute nei meta tag di tale sito sarebbero quindi solo manifestazioni esterne, di importanza secondaria, di tale estrazione e di detto reimpiego.>>
Occorre ancora esaminare <<se gli atti descritti ai punti 35 e 36 della presente sentenza siano tali da arrecare pregiudizio all’investimento del costitutore della banca di dati che è stata trasferita su un altro supporto e che è stata messa a disposizione del pubblico>>, § 38.
L’art. 7. 1 della direttiva 96/9 riserva il beneficio della tutela conferita dal diritto sui generis alle banche di dati <<la cui creazione o il cui funzionamento richiede un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo. Ne consegue che, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi 43 e 46 delle sue conclusioni, il criterio principale di bilanciamento dei legittimi interessi in gioco deve essere il potenziale pregiudizio all’investimento rilevante del costitutore della banca di dati di cui trattasi, vale a dire il rischio che tale investimento non possa essere ammortizzato>>, §§ 43-44.
Valutazione che, immancabilmente, tocca al giudice nazionale, § 46.